All’inizio del Novecento
il mondo della cultura venne ravvivato da
numerosi contributi materiali ed intellettuali.
I nuovi mezzi di trasportoe di comunicazione cambiarono la tradizionale percezione dello spazio e del tempo:
il consolidarsi del trasporto ferroviario e gli albori di quello aereo
accorciarono i tempi di spostamento delle persone, nel contempo la diffusione
dell’automobile permise gli individui di muoversi anche in maniera indipendente;
il telefono rese ancora più rapida e pratica la possibilità di comunicare
offerta dal telegrafo; la radio e il cinematografo ampliavano sia l’offerta
informativa che le possibilità artistiche.
Queste innovazioni furono
indubbiamente il frutto del progresso scientifico e dell’ideologia positivista
che aveva concesso alla stessa scienza una fiducia immensa, ma, nel contempo,
questi cambiamenti mutarono il rapporto dell’uomo con il mondo e misero in
crisi ogni certezza.
 La teoria della
La teoria dellarelatività, elaborata per la prima volta da Albert Einstein
(1879-1955) nel 1905, allontanò l’idea di una possibile comprensione oggettiva
della realtà e, in seguito alla sua formulazione, ci si rese conto che persino
scienze tradizionalmente considerate “esatte”, come la matematica e la fisica,
in realtà non riuscivano ad analizzare il mondo con una visione totale ed
univoca.
In ambito filosofico le
teorie di Friedrich Nietzsche (1844-1900)
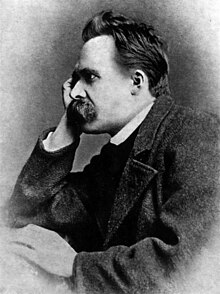 rivoluzionarono questo settore
rivoluzionarono questo settoreculturale, ma il suo pensiero influenzò anche la letteratura, a partire dalla
produzione di D’Annunzio che, tra
l’altro, in molti passaggi tradì l’autenticità del maestro. Nietzsche rinunciava
a qualsiasi fiducia nelle certezze della filosofia tradizionale, sostituì la concezione lineare del tempo con
quella ciclica dell’ “eterno ritorno”, smascherò le illusioni dell’uomo moderno
e le ipocrisie della morale borghese arrivando ad anticipare molte dei futuri
traguardi della psicoanalisi.
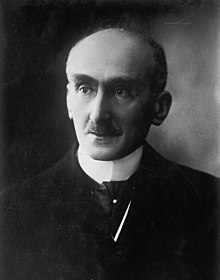 Oltre al filosofo tedesco
Oltre al filosofo tedescoè doveroso ricordare l’importanza delle teorie vitalistiche di Henri Bergson (1859-1941) secondo il
quale la vita è una continua creazione che può essere rivelata tramite l’intuizione
e solo in parte dalla scienza, poiché quest’ultima è impossibilitata a cogliere
tutti gli aspetti della realtà nella loro interezza. Il filosofo francese,
inoltre, contrappose all’idea di un tempo “spazializzato” quella di un tempo
“vissuto”, interiore alla coscienza.
Tutte queste nuove correnti
di pensiero di tipo irrazionalistico e vitalistico contribuirono alla crisi del
Positivismo, ne mostrarono i limiti e resero evidente la sua incapacità di
fornire tutte le risposte necessarie all’uomo desideroso di non fermarsi più
soltanto ad una visione superficiale e fenomenica della realtà. La corrente
positivista, in particolare, aveva cercato di analizzare anche l’interiorità
dell’uomo attraverso criteri meccanici e puramente quantitativi, nella
convinzione che la sfera psichica
obbedisse a precise leggi spiegabili in maniera razionale ed univoca.
L’analisi dell’inconscio,
condotta da Sigmund Freud
(1856-1939), tra Ottocento e Novecento, mise in crisi il concetto stesso di
integrità del soggetto.
Gli studi del medico
viennese influenzarono profondamente tutte le arti, ed egli stesso fu
consapevole della portata epocale delle sue teorie, decidendo di pubblicare L’interpretazione dei sogni (1899)
postdatando l’anno di edizione, per conferire all’opera un carattere di
apertura e non di chiusura di secolo.
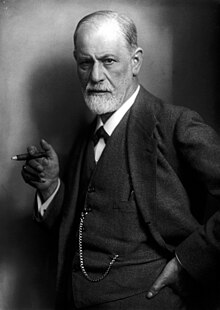 Secondo Freud non bisogna
Secondo Freud non bisognaconsiderare l’uomo come un essere dal carattere unitario, ma al suo interno
egli è diviso tra una zona consapevole, in cui dominano ragione e volontà, e
un’altra inconscia che si manifesta nei sogni, nelle nevrosi, nelle pulsioni
improvvise ed istintive. Gli effetti di queste teorie apparvero, all’inizio,
rivoluzionarie ed antipositiviste, ma l’idea di Freud era quella di studiare scientificamente le
reazioni della sfera inconscia, per poterne controllare gli squilibri e curare
gli eccessi.
Le idee di Freud influenzarono
in maniera decisiva il mondo della cultura, in particolare il campo letterario.
Nel saggio Il poeta e la fantasia (1909) Freud definisce l’arte come un
fenomeno compensativo, in posizione intermedia tra frustrazione ed appagamento.
La teoria dell’inconscio è alla base della
tecnica del “flusso di coscienza” di Joyce, il quale cercherà di riprodurre in
concreto gli accostamenti analogici della mente; le teorie sui sogni
contribuiranno alla nascita della corrente surrealista; l’interesse per
l’infanzia e l’importanza che il fondatore della psicoanalisi attribuisce a
questa età dell’uomo troverà spazio nelle opere dei maggiori prosatori del
Novecento, con particolare riferimento al rapporto padre-figlio, ma anche
quello con la propria madre, soprattutto nell’assenza di una figura paterna
(Tozzi, Svevo, Gadda, Saba).

Nessun commento:
Posta un commento