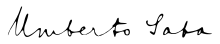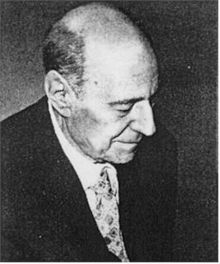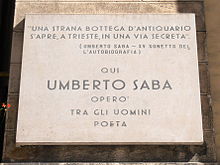Ideazione, stesura, titolo
Ernesto è un romanzo incompiuto, parzialmente autobiografico, pubblicato postumo
nel 1975. L’opera ebbe una lunga gestazione dovuta soprattutto all’incertezza
dell’autore sulla materia da affidare a queste pagine.
 Saba inizia a scrivere il libro nei primi mesi
Saba inizia a scrivere il libro nei primi mesidel ’53, in un periodo in cui prende forma la Prefazione a Poesia
dell’adolescenza,sezione poetica in cui è spinta ai massimi livelli
l’indagine sulla propria infanzia. La prima sezione del Canzoniere, tuttavia, è
vittima di una sorta di «relativa e ormai cristallizzata indeformabilità»[1] per
cui, nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti,queste poesie non riescono a
svolgere a pieno il loro compito di introduzione alla raccolta. Ecco, dunque, che Saba decide di giocare la
partita a carte scoperte in prosa.
Da numerosi riferimenti
presenti nell’Epistolario possiamo
affermare con certezza che l’idea di un romanzo fosse nata molti anni prima del
‘53, anche se la struttura del futuro lavoro cambia spesso forma e i
riferimenti all’opera sono indiretti e contraddittori, ma ripetutamente si
accenna spesso ad un «ultimo libro».
L’autore trova la forza
di mettere in pratica il suo progetto
durante un periodo di cura presso una clinica romana, luogo che gli
offre la giusta serenità e protezione dal mondo esterno e lo rende
particolarmente euforico; si sente finalmente deciso ad affrontare una materia
così delicata e a lungo rimandata.
I primi tre capitoli
vengono scritti velocissimamente (in meno di un mese), gli altri due saranno
aggiunti solo dopo il ritorno a Trieste e con sempre maggiore fatica a causa
della scomparsa di quella parentesi serena creatasi a Roma. Il 31 agosto del
’53 Linuccia Saba scrive a Carlo Levi
Papà non vuole continuare il libro: dice che non ce la fa, che non può
parlare di Ilio e lo vuol troncare. E questo sarà un doppio disastro: primo
perché il libro così incompiuto è brutto, secondo perché papà avrà una crisi di
nervi peggiore della altre. (p. 1298)
La stessa inconcludenza
accompagnerà la sorte di Favole e
Apologhi, a cui Saba stava lavorando in quello stesso periodo, che
sarebbe dovuto diventare l’epilogo del Canzoniere e attraverso il quale l’autore doveva «consegnare il
frutto ultimo degli insegnamenti di una vita».[2]
L’incertezza accompagnò
anche la scelta del titolo: secondo l’analisi di Davide De Camilli[3]
inizialmente Saba aveva pensato a Un mese
o Un anno ( sarebbe dipeso dall’arco
di tempo abbracciato nella narrazione) o anche Intimità (ma forse sarebbe stata troppo evidente la carica
autoreferenziale). La scelta, sempre
secondo De Camilli, cadde sul nome Ernesto che può essere considerato un
acronimo dei vari pseudonimi dell’autore: la sillaba “er” e la conclusione “to”
da Umberto, “ne” da Odone (protagonista della Gallina), la “s” da Saba. Dal Dizionario dei nomi Utet è possibile
ripercorrerne la tradizione letteraria: Tasso, Tassoni, Marino, Goldoni, Verga,
De Amicis e infine in Wilde con L’importanza
di chiamarsi Ernesto, opera teatrale che gioca sulla simile pronuncia del
nome “Ernest” e dell’aggettivo “earnest”, traducibile in italiano con
“sincero”, “onesto” (nella nostra lingua il nome “Franco” ha le medesime qualità
di aggettivo) che potrebbe essere attribuito anche al protagonista del romanzo
incompiuto di Saba e al suo autore che trova il coraggio di affrontare temi a
lungo taciuti.
La struttura: le cinque tappe
Ogni capitolo presenta un
momento decisivo per lo sviluppo della personalità del giovane: esperienza
omosessuale, esperienza eterosessuale, prima rasatura, confessione alla madre,
nascita della vocazione artistica.
Tutto è rivolto alla
conclusione, alla confessione, come se il rito iniziatico non potesse fare a
meno della sua divulgazione, come se la libertà si potesse acquisire solamente
enunciando i propri segreti. La funzione catartica della letteratura è spinta
alle massime possibilità.
Il primo capitolo si apre
con un’autocitazione:
Mi piacerebbe, adesso che sono vecchio,
dipingere, con tranquilla innocenza, il
mondo meraviglioso.
Da Il bianco immacolato
Signore,
in Ricordi-Racconti.
In effetti in queste
pagine Saba rievocherà il suo mondo infantile, ma, seppur vero che la
digressione incomincia in un periodo di relativa serenità, l’opera sarà
tutt’altro che una rievocazione di cose “meravigliose”.
In questo primo episodio,
dunque, il giovane Ernesto, praticante di commercio in una ditta di
compravendita di farina, dialoga serratamente con suo collega di lavoro, più
grande di lui, arrivando ad un rapporto di confidenza molto intimo. Le
reminescenze autobiografiche sono frequenti, dall’ammissione di non aver mai
conosciuto il padre, alla confessione del rapporto difficile instaurato con la
madre. Il giorno dopo si consumerà il primo rapporto omosessuale della sua vita.
Nel successivo episodio
si avverte subito l’insofferenza di Ernesto per quell’uomo.
Forse il povero ragazzo non aveva trovato in quella relazione quel po’ di
protezione paterna, che egli, rimasto più bambino della sua età e virtualmente
senza padre (lo zio tutore contava solo per le sberle e il fiorino settimanale)
inconsciamente cercava. (537)
Per prima cosa gli
rimprovera la confidenza eccessiva, l’uso del “tu”, anche se ciò avviene
soltanto quando sono soli. In seguito, dopo che Ernesto si era assentato per
sette giorni dal lavoro a causa di una febbre intestinale, l’uomo va a fargli
visita, ma è costretto a subire le allusioni e le battute del ragazzo,
sprezzante della presenza della madre in casa. Infastidito dalla reazione
dell’uomo decide di troncare quella relazione che ormai gli procurava soltanto
noia, se non addirittura fastidio.
Alla fine del capitolo
Ernesto racconta all’uomo della sua balia e degli anni felici trascorsi con
lei. Questa figura, tanto cara a Saba, è una delle poche femminili ad essere
presente nell’opera in maniera positiva: la sua presenza è a metà tra quella di
una madre e quella di una donna da conquistare, ma di queste due incarna solo
gli aspetti positivi.
«Anche una baia el gà?» chiese l’uomo.
«Certo che la gò; e ghe voio anche ben. No son miga el solo a volerghe
ben alla sua balia. Ghe sé un grande poeta (el se ciama d’Annunzio) che vivi
ancora e che gaveva anche lui una baia. Adesso el devi esser vecio; ma ehe gà
scrito lo stesso una poesia. El la gà
intitolada Alla mia nutrice. […] Fino ai quattro-cinque ani son visudo in
casa della mia baia, in campagna. Prima, mia mama gaveva perso, per i
dispiaceri, el late. (p. 551)
La sezione del Canzoniere Il piccolo Berto è quella dove maggiormente viene ricordata la
figura della balia, come nella prima delle Tre
poesie alla mia balia:
Al seno
approdo di colei che Berto ancora
mi chiama, al primo, all’amoroso seno,
Nella terza poesia è
evidente come il distacco da questa donna abbia segnato profondamente la
personalità dell’uomo, incapace di dimenticarla anche dopo quaranta anni. La
spezzatura tra “Umberto” e “Saba” è il sigillo della sua personalità ancora
tormentata.
Il bimbo
è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto
di molti beni e molti mali. È Umberto
Saba quel bimbo. E va, di pace in cerca,
a conversare colla sua nutrice;
che anch’ella fu di lasciarlo infelice,
non volontaria lo lasciava. Il mondo
fu a lui sospetto d’allora, fu sempre
La madre non fu mai in grado di conquistarsi
un simile affetto, forse perché, come si capirà meglio nel quarto capitolo,
costretta ad assumere i tratti severi e censori della figura paterna,
abbandonando ogni dolcezza materna.
Nel terzo episodio sono
rievocate altri due eventi iniziatici: il taglio della barba e la prima
esperienza eterosessuale.
Il primo dei due avviene
quasi per caso, dopo che Ernesto si è fatto tagliare i capelli da Bernardo (tra
l’altro questo “rito” è indicato da Freud, nell’opera Totem e Tabù, come un equivalente simbolico della circoncisione),
barbiere di fiducia e, secondo la malelingue, padre dello stesso giovane. È
subito evidente come il taglio della barba abbia gettato il giovane nella
tristezza:
Ernesto finalmente fu lasciato libero e si alzò. Nessuno si accorse che
aveva le lacrime agli occhi. […] Un lieve venticello che si era alzato dal mare
rendeva più molesta la sensazione di freddo che Ernesto provava al collo e alle
guance. Gli pareva di essere rimasto
nudo, e non vedeva l’ora di essere a casa. Sperava – pur sapendo che la sua
speranza era vana – che sua madre avrebbe saputo confortarlo. (561)
La rasatura (improvvisa,
«a tradimento» dirà alla madre) è il segno della crescita, sigilla l’abbandono
dell’età puerile, l’età dell’innocenza e già alla fine del secondo capitolo si
era rammaricato dell’imminente compimento dei diciassette anni. Ernesto è come
agitato da un pensiero, dal rimorso di aver concesso la sua prima esperienza
sessuale ad un uomo, proprio alla soglia dell’età adulta. Pensa agli amici che
hanno avuto un’esperienza eterosessuale prima di lui e si convince
all’improvviso, spinto dalle pulsioni dell’inconscio più che dal ragionamento:
«Se mi sverginassi, oggi, adesso, subito!» fu la conclusione a cui
giunsero le meditazioni e le melanconie di Ernesto. (p. 563)
Decide di andare da una
donna che esercitava il mestiere da sola nella Città Vecchia, quartiere
popolato da prostitute e vagabondi, ma tutt’altro che negativo per Saba. Nella
raccolta Trieste e una donna una
poesia intitolata proprio Città vecchia
testimonia l’amore per questo luogo in cui il poeta si sente davvero vivo.
Spesso,per ritornare alla mia casa
prendo un’oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale,e affollata è la strada.
Qui tra la gente che viene che va
dall’osteria alla casa o al lupanare,
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo,passando,l’infinito
nell’umiltà.
Qui prostituta e marinaio,il vecchio
che bestemmia,la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore,
la tumultuante giovane impazzita
d’amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s’agita in esse, come in me,il Signore.
Qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi
Il rapporto con la
prostituta si consuma tra gli imbarazzi ed i pensieri del giovane. Torna
continuamente alla mente di Ernesto la figura della balia.
[…] Era un odore di biancheria nuova, appena tagliata; lo stesso che gli
piaceva tanto nella casa della sua balia. […] non aveva la licenza (come forse
non l’aveva la donna da cui era salito Ernesto.
[…]Evidentemente, la donna era una slovena del Territorio. Era un’altra
somiglianza tra lei e la balia di Ernesto: queste coincidenze accrescevano, forse,
il suo imbarazzo. (p. 568)
Uscito dalla casa della
donna cerca subito una fontanella dove bere, ma ne trova soltanto una affollata
da molte donne in fila per fare provvista d’acqua. Una di queste invita le
altre a farlo passare avanti, dicendo: «Ma lassé dunque bever sto povero fio de
mama. No vedè che el mori de sede?». Una simile frase era stata pronunciata poco
prima dalla prostituta e, sommando questo pensiero alle risate della ragazze
presenti, Ernesto si sente profondamente agitato, turbato, quasi come se fosse
stato scoperto.
Alla fine del terzo
capitolo, dunque, il giovane Ernesto ha già avuto un’esperienza omosessuale ed
una eterosessuale. Il giovane sembra perdersi alla ricerca della sua vera
identità, sospeso in una condizione di bisessualità “innocente”, indotta non
dalla spregiudicatezza del fanciullo, ma dalla sua incapacità a decidere, quasi
come se questa condizione fosse propria dell’adolescenza, originaria di ogni
individuo fino alla pubertà. «All’inizio sono tutti bisessuali […] può avvenire
che più tardi loro stessi favoriscano attivamente la propria formazione
unilaterale verso un sesso». Questa citazione potrebbe appartenere al romanzo
incompiuto, invece è propria del “cattivo maestro” di Saba, Otto Weininger, che
abbiamo visto influenzare le raccolte narrative dell’autore triestino, Ebrei e L’eterna lite. Le coincidenze tra il romanzo e l’opera Sesso e carattere non finiscono qui: «lo
studioso austriaco riconosce l’esistenza soltanto di due tipi di donna, la
madre e la donna prostituta, e una madre
e una prostituta sono le uniche due donne che compaiono nel romanzo»[7]
Il quarto episodio è quello
della confessione alla madre. Ernesto si licenzia dal suo impiego con una
lettera rovente indirizzata al suo principale, il signor Wilder, facendo in modo che costui la leggesse in sua
presenza, quasi per ricevere la soddisfazione di essere cacciato di persona.
Tornato a casa confessa
alla madre questo ultimo avvenimento, gettando la donna nello sconforto e nella
delusione, quasi il figlio rappresentasse un secondo fallimento dopo il marito.
La signora Celestina si reca subito dall’ex principale e riesce a convincerlo a
riassumere il figlio. Tornata a casa, però, Ernesto si infuria con lei:
Ce l’aveva anche (a torto; lo riconosceva) con sua madre: questa non
poteva infatti indovinare la “vera causa” per cui si era fatto mandar via dal
signor Wilder. […] Infatti, anche se fosse andato in ufficio la sola mattina, si
sarebbe ugualmente incontrato con l’uomo. Come dirlo a sua madre? Come
farglielo capire? (p. 604-605)
In maniera contorta e
confusa riesce a confessarle la relazione omosessuale, cui seguirà la reazione
della madre prima indignata (lo chiamerà anche «assassino, peggio di tuo…», poi
rabbiosa nei confronti dell’uomo, infine «La signora Celestina (e fu un
miracolo) capì, questa volta, che suo figlio aveva più bisogno di essere
consolato che rimproverato». Abbiamo
osservato la ricorrenza, nel Canzoniere,
dell’appellativo «assassino» che anche in questo romanzo la donna rivolge al
marito, ma è possibile stabilire ancora una volta un collegamento tra Saba e
Nietzsche che, in un suo aforisma, si sofferma sulla possibilità che tutti
siano potenzialmente “colpevoli”.
L’«assassino», che noi condanniamo, è un fantasma: «L’uomo che è capace
di un assassinio». Ma di ciò siamo capaci tutti.[8]
Ernesto concluderà la confessione con il
racconto dell’incontro con la prostituta, cosa che aumenterà ancora di più il
dolore della donna, mentre il giovane sperava che questo secondo episodio
potesse pareggiare il primo annullandone la negatività. Nonostante la sincera confessione sia
finalmente avvenuta non si può fare a meno di notare come il rapporto
madre-figlio risulti ormai definitivamente compromesso; ad un certo punto la
donna sembra più intenzionata ad assicurarsi che nessuno venga a sapere delle
esperienze del figlio piuttosto che preoccuparsi dell’effetto che queste
potrebbero aver avuto su di lui. In qualche modo è come se, a causa della
mancanza di una figura paterna, ella «non riuscisse a svolgere il suo ruolo
naturale di mediatrice tra padre e figlio»[9], ma è
costretta ad assumere il doppio ruolo di padre e madre: è la donna a
rappresentare il principio di autorità che di solito spetta all’uomo, e il
fanciullo si trova costretto a cercare figure affettive “materne” altrove:
nell’uomo con cui ha avuto l’esperienza omosessuale, che all’inizio lo tratta
con molto affetto; nel barbiere Bernardo, tanto protettivo nei suoi confronti
come se avesse capito lo stato d’animo del giovane dopo la prima rasatura;
nella prostituta, che si prende cura di lui con tenerezza prima e dopo il
rapporto.
Nella Quasi conclusione (scritta nel 1953), che precede l’ultimo capitolo,
l’autore motiva la scelta di interrompere l’opera affermando di sentirsi troppo
vecchio per portare avanti il lavoro, rimarcando le sue precarie condizioni di
salute, rammaricandosi della perdita del dolce ambiente romano. Certo queste
spiegazioni hanno un fondamento, ma non si può fare a meno di osservare come
l’opera appaia esauriente già dopo solo cinque capitoli, abbondantemente
sufficienti a delineare lo sviluppo interpersonale del giovane e dello stesso
autore. Spesso Saba confessò la sua paura che l’opera si allargasse a dismisura
inglobando ed “uccidendo” lo stesso Canzoniere
ed il timore è perfettamente giustificato. La conclusione dell’Ernesto, infatti, collima perfettamente con l’inizio della raccolta
poetica (Poesie dell’adolescenza che,
non a caso, Saba passerà in rassegna nello stesso ’53) e un eventuale proseguimento del libro
avrebbe rischiato di sovrapporsi, forse fatalmente, alle liriche. La prosa
fornisce così la possibilità di integrare le poesie dell’adolescenza, ma anche
di andare oltre la loro cristallizzazione, di trattare la materia in modo più
preciso.
L’interruzione è
motivata, inoltre, dal timore dell’autore di andare troppo avanti con la
confessione, svelando particolari “proibiti”. Nell’ultimo capitolo compare
Ilio, un giovane studente di violino. La presenza del fanciullo non può essere
giustificata dalla voglia di sperimentare ancora le curiosità della vita, non
può essere considerata un ulteriore surrogato di padre (dopo “l’uomo”, il
padrone, lo zio, il barbiere). La passione per questo giovane non è
giustificabile con la voglia di sperimentare nuove emozioni: è una scelta quasi
matura, ragionata, e allora Saba decise di sopprimere Ernesto e le sue “colpe”.
In questo quinto episodio
torna a fare capolino un altro dei tre “maestri” che da sempre hanno
influenzato la scrittura dell’autore: si tratta del Nietzsche della Nascita della tragedia, a metà tra
apollineo e dionisiaco così come si presenta la figura di Ilio.
La figura del giovane Ilio è molto
simile a quella di Glauco, amico di
infanzia del poeta, presente nella raccolta Cuor
morituro, ma soprattutto, protagonista di un’omonima poesia della raccolta Poesie dell’adolescenza e giovanili:
Glauco, un fanciullo dalla chioma
bionda,
dal bel vestito di marinaretto,
e dall’occhio sereno, con gioconda
voce mi disse, nel natìo dialetto:
tu consumi la vita, e par nasconda
un dolore o un mistero ogni tuo
detto?
Perché non vieni con me sulla sponda
Del mare, che in sue azzurre onde
c’invita?
Qual è il pensiero che non dici,
ascoso,
e che da noi, così a un tratto,
t’invola?
Tu non sai come sia dolce la vita
Agli amici che fuggi, e come vola
Lingua e stile
Saba riteneva l’opera
impubblicabile a causa degli estremismi linguistici della stessa perfettamente
accordati allo scandalo tematico (lo sviluppo della persona era in primo luogo
quello sessuale, più nello specifico omosessuale). Già al termine della stesura
del primo episodio cominciarono a sorgere dei dubbi nell’animo dell’autore come
appare chiaramente in una lettera a Lina del 30 maggio 1953 scritta dalla
clinica romana in cui era ricoverato.
Tutte le persone alle quali l’ho letto […] dicono che è la cosa più bella
che io abbia scritto. (Anche io credo.) Disgraziatamente, è impubblicabile: per
una questione di linguaggio. […] la non pubblicabilità del racconto non sta
tanto nei fatti narrati quanto nel linguaggio che parlano i personaggi. E tutta
la novità, tutta l’arte, tutto lo stile del racconto (che potrebbe fermarsi a
questo primo episodio) sta proprio qui. (p. 1292)
Da un punto di vista
lessicale, dunque, non ci sono giri di parole o reticenze, ma le cose sono
definite in maniera precisa, quasi cruda, come solo una confessione sincera può
essere:
«Mettermelo in culo» disse, con tranquilla innocenza, Ernesto.
[…]
Con quella frase netta e precisa, il ragazzo rivelava, senza saperlo,
quello che, molti anni più tardi, dopo molte esperienze e molto dolore, sarebbe
stato il suo “stile”: quel giungere al cuore delle cose, al centro arroventato
della vita, superando reticenze ed inibizioni, senza perifrasi e giri inutili
di parole. (525)
I lessemi utilizzati non
si nascondono dietro perifrasi, ma conservano tutta la loro forza d’urto e la
capacità di creare scandalo in una tradizione letteraria satura di reticenze. E
ciò non avviene soltanto in prosa, ma anche nelle poesie di Saba, nelle quali
il lessico dei sentimenti non è trattato con cautela o eufemismi. D’altronde lo
stesso autore diede conferma di ciò in Amai:
Amai trite parole che non uno
osava. M’incantò la rima fiore
amore,
la più antica difficile del mondo.
Amai la verità che giace al fondo,
quasi un sogno obliato, che il dolore
riscopre amica. Con paura il cuore
le si accosta, che più non l’abbandona.
Amo te che non mi ascolti e la mia buona
Saba porta a termine
quella ricerca di un linguaggio preciso e netto che aveva iniziato decenni
prima. La sua particolarità sta nell’aver trovato questo linguaggio incisivo
facendo un ulteriore passo indietro, mettendo su carta la sua “preistoria”, gli
avvenimenti della sua vita precedenti alla scoperta della vocazione artistica. In
una lettera a Vittorio Sereni del 22 febbraio 1948 si accenna ad un libro che
avrà un impatto rivoluzionario, soprattutto dal punto di vista stilistico, sia
nel panorama culturale nazionale sia per la sua personale storia letteraria.
La spiegazione, il chiarimento – attraverso lo stile – della crisi che
imperversava; un passo ancora al di là delle Scorciatoie. (p. 1293)
L’Ernesto è redatto in italiano per quel che concerne le descrizioni e le
narrazioni, mentre la lingua dei dialoghi è il triestino.
[…] Questo dialogo (che riporto, come i seguenti, in dialetto; un
dialetto un po’ ammorbidito e con l’ortografia il più possibile italianizzata,
nella speranza che il lettore – se questo racconto avrà mai un lettore – possa
tradurlo da sé) si svolgeva a Trieste, negli ultimissimi anni dell’Ottocento. (p.
516)
Saba, quando parlava di impubblicabilità del
romanzo, non si riferiva all’eventuale difficoltà che i parlanti non
dialettofoni avrebbero avuto, ma, come abbiamo detto, alla scelta di definire
le cose in maniera fin troppo esplicita.
L’italiano è sempre stata
la lingua letteraria della penisola, il codice alto della nostra cultura, e
allora ecco che il dialetto poté svolgere la funzione di veicolare le tematiche
più “basse”, proprio perché lingua materna dotata di maggiore naturalezza. Non
c’è nessuna reticenza, quindi, nella scelta di voler utilizzare il triestino,
sia perché la forma utilizzata è più vicina a quella di un italiano regionale
(in generale il dialetto è ammorbidito, italianizzato ortograficamente) , sia
perché i termini più difficili sono tradotti in italiano. Al massimo questo
codice può aver offerto la possibilità di diluire il messaggio scabroso, poiché
appariva lontano alla maggior parte dei
lettori.
Il dialetto, dunque,
rappresenta un ritorno alle origini, offre la possibilità di riconquistare
l’innocenza perduta nominando e delineando le cose tramite la forma originaria.
Se l’italiano ha il compito di veicolare le spiegazioni della storia e il lato
razionale di essa, al dialetto spetta il compito di formulare le emozioni, ma
senza mai andare troppo oltre. L’autore sembra intenzionato a riprodurre la
cadenza triestina più che la gergalità pura.
La presenza del dialetto
è già innovativa di per sé, non c’è bisogno di doverlo spingere all’estremo: lo
stile, infatti, non è turbato dalla presenza del vernacolo, ma è “movimentato”
grazie alla fitta presenza di parentesi, trattini, virgolette, pause,
spezzature del discorso, inversioni e anticipazioni :
- Iddio castiga,- disse allora, diventato, per una volta tanto, ipocrita,
Ernesto, che aveva perduta di colpo la fede, il primo giorno che s’era, sul
consiglio esempio del cugino corruttore, masturbato.
[…]
Il quale [Stefano] – non c’è persona, per quanto arida, che non abbia,
qualche volta, uno slancio generoso – pensò, per un momento, di corrergli
dietro e di stringergli, per comunanza d’età, la mano.
Oltre a queste due lingue è utile soffermarsi
sulla presenza di una terza: il tedesco. La lingua germanica è utilizzata non
attraverso i calchi tipici della prosa sveviana, ma è presente con formule
cristallizzate, stereotipate, e Saba la traduce in ogni occasione. La lingua
dei dominatori è rievocata solo come struttura, come forma ormai scissa da ogni
significato di potenza, come scarto linguistico.
Nel dodicesimo sonetto di Autobiografia (1924) Saba dà un
definizione della raccolta Trieste e una
donna:
12
[…]
Trieste è la
città, la donna è Lina,
per cui scrissi
il mio libro di più ardita
sincerità; ne
dalla sua fu fin’
Senza nulla togliere a
questa considerazione, che comunque resta valida per quanto riguarda il Canzoniere, non c’è dubbio che con l’Ernesto si sia spinto oltre sul versante
tematico dell’onestà e su quello stilistico della forma arida e diretta. Ha
raggiunto in prosa quei traguardi che, forse, non poteva conseguire in poesia.
L’audacia linguistica va
di pari passo con l’architettura formale del libro, completamente diversa da un
romanzo di formazione ottocentesco, «mirante a cogliere i rapporti di causa
effetto nelle reazioni sentimentali tra i personaggi»[13], ma
nell’Ernesto tutto si svolge
all’interno del protagonista, e sono semmai i suoi turbamenti psicologici ad
avere un’ influenza sul mondo esterno e non viceversa. Di ottocentesco c’è solo
la «scelta distanziante della terza persona come mediatrice del racconto»[14].
La sincerità del discorso
risponde ad un bisogno fondamentale dell’autore: essere compreso, condiviso e
assolto, entrare in contatto diretto con il lettore ed infatti “coerente con
questo sviluppo è una parte sostanziale delle esperienze biografiche e di
quelle letterarie di Saba”.[15]
Certo solo un grande
scrittore poteva riuscire nel miracolo di chiamare le cose col loro nome,
spingendosi fino alla descrizione realistica di un rapporto omosessuale, ma riuscendo
contemporaneamente a mantenere un tono candido, innocente.
Scriverà Elsa Morante in
una locandina con cui l’Einaudi accompagnerà l’uscita dell’opera:
Le stesse cose che altri, nel dirle, potrebbero rendere oscene, o
ridicole, o sordide, si rivelano invece, dette da Saba nelle loro chiarezza
reale, naturali e senza offesa. Lasciando limpida, alla fine della lettura,
l’emozione degli affetti.
[3] D. De Camilli, Da
Umberto ad Ernesto, in Id., «Si pesa
dopo morto» , «Rivista di letteratura italiana», XXVI, 1. p. 23-29.
[7] A. Cinquegrani, L’officina
di Ernesto , in Id., Saba
Extravagante, «Rivista di letteratura italiana», XXVI, 2-3, p. 410.
[8]
F. Nietzsche, Frammenti postumi 1879-1881,
in Opere di Friedrich Nietzsche, a cura di
Giorgio Colli e Mazzino Montinari, traduzione di Mazzino Montinari e Ferruccio
Masini, Milano, Adelphi, 1964, p. 274.
[14] A. Daniele, Lingua e
dialetto nell’Ernesto di Saba, in “Studi novecenteschi”, n. 16, 1977, p.
97.
[15] G. Mura, Il
livello emozionale del discorso in Umberto Saba, in Id., Saba Extravagante, «Rivista di
letteratura italiana», XXVI, 2-3, p. 240.
N.B.: Testo estratto da una tesi di laurea. Tutti i diritti riservati.